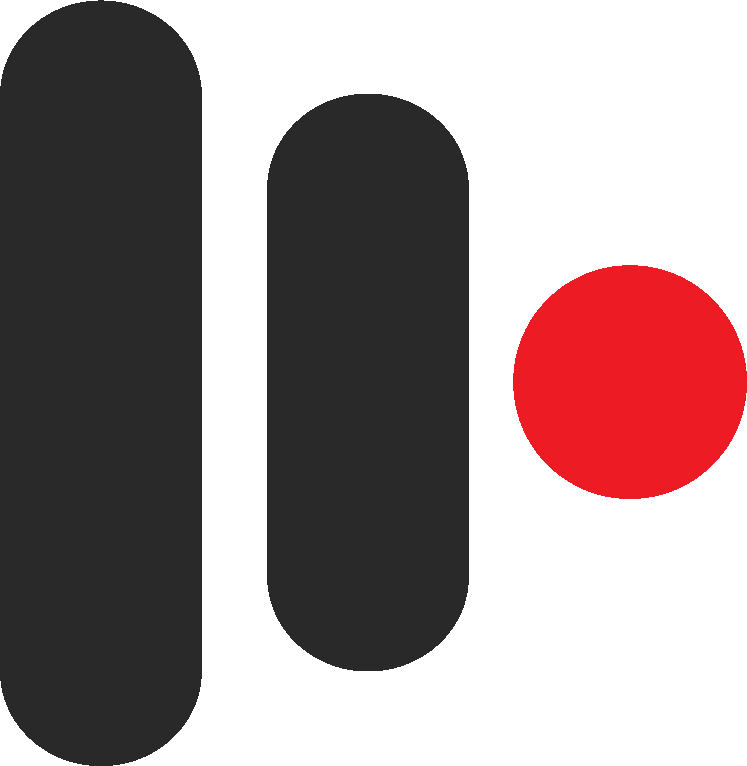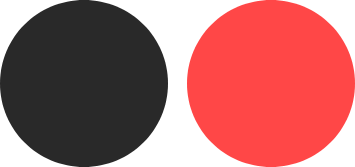Filmati di falso found footage, disturbati e di bassa qualità, documentano l’oscurità violenta di riti svolti in inquietanti cerchi bianchi, tra corpi gonfi o deformati da strazianti convulsioni, visioni, tentativi di impiccagioni.
Una ragazza in outfit quantomeno sgargiante, sportivo, anni Novanta, esce da scuola. La seguiamo di spalle e, alla fermata dei bus, cerca uno scambio di parole con tre compagne di classe. Queste la guardano con sospetto e derisione, senza un apparente motivo che ci viene però disvelato dopo poche battute. Passiamo al mezzobusto frontale di Piper (Sora Wong), che è propositiva e loquace, sì, ma ipovedente, con un occhio socchiuso e uno strabico. Arriva dunque il fratello Danny (Billy Barratt) che, preoccupato e protettivo, la redarguisce per non aver atteso che lui la venisse a prendere, e la porta via tentando di mentirle sullo snobismo quasi schifato delle compagne.
I due ragazzi sono figli di due diverse madri, entrambi assenti, e di un padre in piena chemioterapia che chiamano a gran voce una volta tornati a casa. Questo però non risponde, e al silenzio dell’abitazione vuota s’oppone solo il distinto suono del soffione della doccia, da cui l’acqua continua a scrosciare.
Danny sfonda la porta. Il padre è nudo, riverso a terra senza respiro né battito. Gli occhi semi capovolti e rossi, la bocca divaricata e sporca di quello che pare vomito misto ad altri fluidi interni. Danny cerca di nuovo di mentire a Piper, che però – nonostante non veda che ombre e vaghi barlumi – s’accorge di tutto, si china sul padre e tenta di rianimarlo bocca a bocca. Non c’è nulla da fare. I medici portano via l’uomo e il centro di assistenza sociale assegna Piper ad un’altra donna.
Nonostante gli iniziali problemi – la donna voleva con sé solo Piper – , anche Danny riesce a farsi prendere in affidamento con la sorella, tanto per la paura dei due di essere divisi, quanto per la promessa del fratello che, già noto al centro per atteggiamenti violenti avuti in giovanissima età, s’impegna a comportarsi bene per i prossimi tre mesi, quando sarà maggiorenne e legalmente capace di richiedere l’affidamento esclusivo di Piper.
Giunti nella loro nuova casa, il quadro appare come gradualmente sempre più inquietante: di fronte all’ingresso c’è un grosso cerchio bianco di gesso cosparso a terra; la padrona di casa, Laura (Sally Hawkins), è tanto schiva e disinteressata a Danny quanto già morbosamente dolce e affezionata a Piper, a cui dà la curatissima stanza della defunta figlia morta Cathy – anche lei ipovedente – , a fronte di quella assegnata a Danny, che è poco più di uno sgabuzzino; infine, un piccolo e calvo bambino a torso nudo si aggira per la casa…è Oliver (Jonah Wren Phillips), nipote di Laura che lo spaccia a Piper come rosso e riccio, ma che ha occhi grandi e fissi, e soffre di un mutismo selettivo che risalirebbe ai giorni della tragica scomparsa di Cathy, annegata in piscina.
Non è per il solo sfizio dello storytelling che vi riportiamo per estese – più o meno – le fasi introduttive di Bring Her Back – Torna da me; bensì lo facciamo per meglio “accompagnarvi”, per contestualizzare assieme quanto il secondo lungometraggio dei fratelli Danny e Michael Philippou – già autori dell’apprezzatissimo Talk to Me (2022) – sappia calarsi perfettamente in un intricato sistema condiviso di rimandi e tematiche, prassi e ricorrenze che sempre più nettamente contraddistinguono l’identità dell’horror anglofono contemporaneo. Dettami e semantiche che i registi australiani ora subiscono e ora sfruttano, rimodulandoli alla luce di un’autorialità in crescita che – con Bring Her Back – non fa che confermarsi, aumentare in audacia, dando adito a ottime speranze per il futuro.
Diamo per scontato che tutti abbiate internet, quindi Instagram, You-Tube, Tiktok; e che quindi vi sia capitato di imbattervi nei vari trailer e teaser di questo film che, a posteriori, consideriamo meritevole del discreto hype scaturito. Ci riserviamo dunque anche di non considerare spoiler la malintenzionata follia del personaggio di Sally Hawkins, che oltretutto è nell’aria già dai primi minuti della sua comparsa in scena.
Laura è di fatto l’epicentro ansiogeno, ritmico e tematico della narrazione, in cui la magistrale interpretazione di Sally Hawkins sostiene evoluzione e disvelamento di una umanissima villain, perfettamente in linea con le oramai iconiche madri che da Babadook (The Babadook, 2014, Jennifer Kent) sino ad Hereditary – Le radici del male (Hereditary, 2018, Ari Aster, di cui in questo senso si potrebbe citare anche Beau ha paura, o Beau Is Afraid, del 2023, ma limitiamoci ai film riusciti), e passando per i forse meno conosciuti – e di certo meno mirabili, seppur interessanti – Hole – L’abisso (The Hole in the Ground, 2019, Lee Cronin) o Il morso del coniglio (Run Rabbit Run, 2023, Daina Reid), hanno rimodulato nel genere la recente figura materna: da agente di cura, bontà e sicurezza, a materia fragile, soggetto frustrato da una routine di responsabilità attese che cova rabbia e odio, e che, sottoposta all’inaccettabile dolore del lutto – con l’opzionale aiuto di malattie mentali o possessioni di sorta – , rivela certi lati oscuri in epiloghi quantomai disturbanti…ma non finisce qui.
In Bring Her Back ritroviamo lo stretto rapporto tra un fratello fragile e una sorella socialmente “diversa” (vedasi Peter e Charlie, sempre in Hereditary); il lutto o la scomparsa familiare quali motori di emersione di dinamiche che trasformano la madre, la casa o i rapporti affettivi in dubbi, paure, rabbie e assurdi – ma mai troppo, sono pur sempre horror – sospetti soprannaturali, come ancora in Hereditary, ma anche in Midsommar – Il villaggio dei dannati (Midosmmar, 2019, Ari Aster), The Witch (2015, Robert Eggers) o addirittura nel Suspiria di Luca Guadagnino (2018); e abbiamo infine la magia, i culti spiritici, l’esoterismo e la paranoia, l’ossessione psicopatologica reale che fa tutt’uno col soprannaturale, e che attecchisce in case isolate o di splendido e moderno design, in questo scontro semantico tra uno stile di vita contemporaneo e illuminato che, pur rifuggendo o dimenticato l’antico, ricorre alle sue potenti oscurità per necessità emotive – caratteristiche di setting condivise da più o meno tutti i film finora citati, così come condividono i pessimi esiti delle vicende e, quasi sempre, produzioni e distribuzioni firmate A24.
In un panorama contenutisticamente tanto ricco e deciso – e persino reiterante, a rischio del conformismo estetico – , i fratelli Philippou non perdono però di vista quanto di buono fu caratterizzante nel successo di Talk to Me, sì omaggiando più o meno direttamente i menzionati esponenti del genere – si pensi all’arrivo di Danny e Piper a casa di Laura, in cui, dalla quinta di un utensile da giardino circolare, la camera ruota e si storce come accadeva per l’arrivo dei protagonisti di Midsommar al villaggio svedese, a marcare visivamente l’ingresso in una realtà esperienziale altra – , variando però la formula con piccole ma azzeccate trovate sceniche.
Il personaggio di Piper, ad esempio – che è il nostro primo punto di focalizzazione/immedesimazione nella storia – , con il suo “non vedere”, ben rappresenta e incarna la frustrazione spettatoriale del “non sapere”(rispetto alle vere intenzioni di Laura, al passato violento di Danny, al funzionamento del rituale che fa da incipit alla storia vera e propria), alla mercé delle macchinazioni della padrona di casa, che di mestiere fa la psicologa, e che sa essere manipolatoria tanto con le mancanze fisiche della ragazza quanto con la sopita rabbia di Danny. Questi due, se ci si pensa, sono passive vittime di ciò che la donna vuole fargli vedere, sapere e credere, così come lo è lo spettatore nelle mani del film e dei suoi autori, per un sistema meta-riflessivo in cui l’inquietante, ferale e animalesco piccolo Oliver diviene – senza dire troppo – il “device” che, appunto, nelle mani di Laura, altera esperienze e certezze di Piper e Danny, pedine più o meno scientemente selezionate per far sì che la donna possa far tornare la sua defunta figlia da lei. Ma riguardo ciò, e semiotica del medium a parte, passiamo rapidamente proprio da Oliver, la cui identità di personaggio è anch’essa un mistero che non vi sveliamo, ma che può avvalersi di un’impressionante performance fisica dell’esordiente Jonah Wren Phillips, dagli occhi ora vigili ora spiritati e che, nella sua perenne indecidibilità e imprevedibilità, è protagonista dei più convenzionali eppur potenti momenti di puro horror, in un film che altrimenti si sarebbe giocato sull’esclusiva – seppur profonda e convincente – indagine dell’esperienza umana nella perdita.
Se infatti si può parlare del personaggio del piccolo umano rapato come della più azzeccata delle trovate dei Philippou in questo Bring Her Back – la mina vagante per la casa, che in un sol colpo inserisce nel film autolesionismo, cannibalismo, possessione e quel minimo di “detection” – , più opaco risulta l’incasellamento dei compiti strutturali del rituale da cui i poteri di questo bambino/creatura prendono forma. E questo perché, oltre ad essere mostrato in apertura – ed efficacemente – quale “chiave atmosferica”, per dare il giusto mood ad una vicenda che altrimenti si aprirebbe nella più neutra e quotidiana situazione di quiete – e come oramai è fin troppo consuetudine del genere – ; lo sporadico richiamo del rituale ora nelle cassette che Laura vede per rinfrescarsi la memoria sul da farsi, e ora nei cerchi di gesso nella e intorno a casa sua – dentro cui/fuori dai quali Oliver va in preda a tremende grida e strazianti contorcimenti – , sembrano sì aver il ruolo di istruirci sul funzionamento del rito, ma mai fino in fondo.
Il tutto è forse più comprensibile se si sommano le informazioni dei found footage a quelle che intuiamo dai singoli e misteriosi atti di Laura, di Oliver, e dagli effetti che questi hanno su Piper e Danny, pur non risultando mai del tutto chiaro e afferrabile.
Che sia tutto volontario? Che i fratelli Philippou abbiano volontariamente lasciato quello spiraglio di interpretazione e ambiguità per rifiuto di piegarsi all’oramai sdoganata norma dello “spiegone” paranormale?
È possibile, e per supporlo basta pensare al precedente Talk to Me, in cui la morte della madre della protagonista non viene ma chiarita del tutto, il limite tra effettivi accadimenti paranormali e un’ereditarietà di patologie psichiatriche non viene mai davvero rivelato e, soprattutto, tra i cui statuti principali c’è quello che le presenze, insondabili come sono, mentono, e a ciò bisogna arrendersi.
Quasi lo stesso avviene in Bring Her Back, ma con l’unica eccezione di una leggera sovrabbondanza di stimoli e quesiti, funzionamenti tanto attivi nell’evoluzione degli eventi da far sì che – anche al secondo film di una breve carriera sinora giocata su conoscenze che appartengono a mondi incomprensibili – il decreto su volontarietà o meno di alimentare col dubbio il fascino dell’esperienza è rimandato, e sarebbe legittimo supporre la svista.
Eppure il fascino rimane, lo si avverte e lo si porta con noi ben oltre la visione.
Bring Her Back è una seconda opera in tutto e per tutto. Seppur nell’evidente evoluzione qualitativa di una messa in scena che già convinceva, è – come di consueto – meno solida di Talk to Me, vero, ma è più coraggiosa e ispirata perché abbandona le rassicuranti sponde di sintattiche horror funzionali ma lineari, abbracciando le complessità di un’umanità fragile, cattiva, rabbiosa e amorevole, che in onore di certe opposte convivenze sbaglia, e che, al confronto con l’ultraterreno, accetta le incontrollabili implicazioni della paura nel tentativo di rimediare ai propri errori.
I Philippou rinnovano la fede nella più viscerale e classica cultura horror: nell’irrinunciabile gusto di effetti analogici eccelsi, fisici e conviventi con quelli digitali senza mai soccombervi; ribadiscono lo zeitgeist di un orrore che nasce da noi, che a nostra volta nasciamo dalle nostre famiglie, e con l’hereditary che questo comporta; proseguono infine un discorso rischiosamente in bilico tra bugia e verità, resa all’ignoto e all’inconoscibile, portando in sala un film che deluderà chi cerca risposte, dal momento che – esattamente come per Piper e Danny – a noi non stanno pretese su ciò che (di noi stessi) ci è dato sapere.