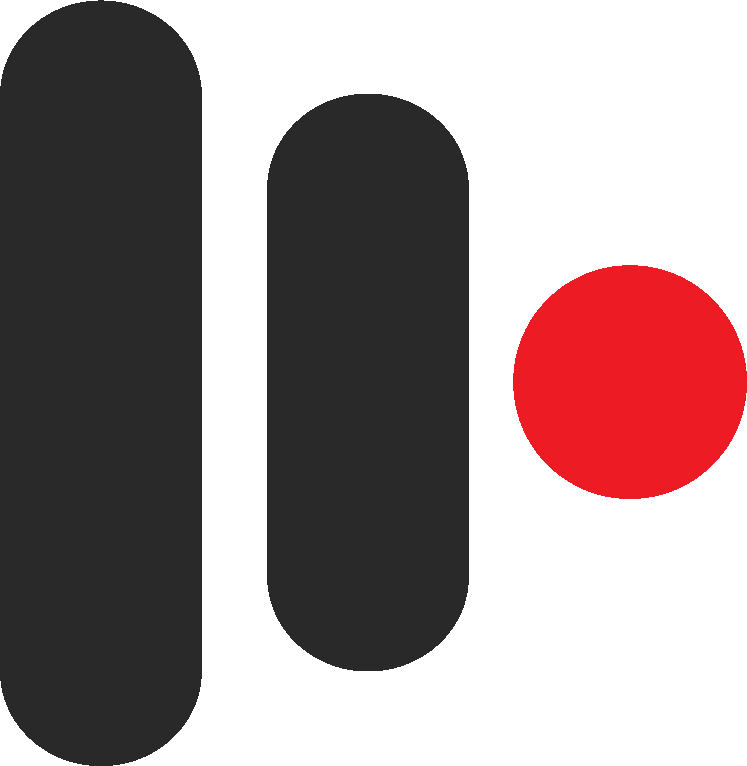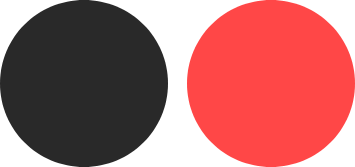Il regista e comedian di Arlington, Virginia, Zach Cregger, torna in sala dopo tre anni dall’incoraggiante risultato di Barbarian (2022) espandendone i già interessanti stilemi stilistici e narrativi, replicandone tanto le gravi pecche quanto le invidiabili e brillanti intuizioni, con una seconda opera – perché di opera si tratta, e sotto quasi ogni aspetto – che però, rispettivamente, smussa le prime e fa esplodere le seconde. Il risultato è un racconto vario e stratificato, non esente dal divenire un altro ingrediente nel calderone degli elementi che oramai fin troppo spesso sostanziano l’horror contemporaneo, ma che, come l’eccellente Bring Her Back – e in questo caso forse anche di più – , parte dalla norma per promettere al genere cicli nuovi, coraggio, divertimento e fascinose rivitalizzazioni di immaginari oramai ben assodati.
Dunque…
L’innocente voce narrante di una bambina – che rimarrà sempre fuori campo e a cui mai daremo un volto – ci introduce la vicenda come la strana storia che è, come in un podcast true crime, come una favola che è più nera del quadro vuoto su cui risuonano le prime parole del film:
«This is a true story.»
«A lot of people die in a lot of really weird ways.»
È una semplice mattinata tra estate e primavera a Maybrook, quando – come in una qualsiasi altra mattinata alla Maybrook Elementary School – la maestra Justine Gandy (Julia Garner) apre la porta della sua classe. I banchi sono però vuoti, tutti, tranne uno: quello di Alex Lilly (Cary Christopher), l’unico ad essersi presentato a lezione.
La comunità viene colta da comprensibili e generalizzati stati di ansia e inquietudine, alimentati dal mistero di un fatto che non ha ancora né “come” né “perché”.
La polizia apre le indagini, trovando barlumi di soluzioni nelle riprese estrapolate da alcuni dei citofoni elettronici che stanno alla porta delle villette a schiera delle famiglie dei bambini. Le risposte però, se possibile, risolvono solo parzialmente le domande di cui sopra, alimentandone al contempo la portata di dubbi e paura: alle 2:17 della notte precedente all’assenza di gruppo in classe, diciassette occhi elettronici di diciassette villette hanno registrato diciassette bambini uscire di casa correndo in linea retta – entrambe le braccia tese perpendicolari al corpo, le mani strette e vagamente arcuate come lance, o ali – percorrere qualche decina o centinaio di metri, per poi sparire nell’oscurità di quella notte. Il piccolo Alex, unico sopravvissuto, dichiara di non sapere nulla rispetto all’accaduto.
Ed è a fatto oramai compiuto che Weapons inizia, nella sala riunioni in cui la scuola ha convocato genitori spauriti e arrabbiati, professori e uno psicologo comportamentale, nel tentativo di favorire un’elaborazione collettiva di un evento che – con buona pace dei sacrosanti, funzionali e necessari lineamenti psicoterapeutici – pare nascondere qualcosa di assai più oscuro, insondabile e pericoloso, predisponendo i poveri cittadini a tensioni a reazioni che promettono di esserlo altrettanto.
Cregger ci cala dunque nel secondo dei vari mood situazionali che compongono il più o meno complesso puzzle di Weapons: dopo un prologo – come detto – da favola nera/crime, ecco il dramma sociale e collettivo di una piccola comunità in preda all’incredibilità di eventi che effettivamente appaiono tali, passando subito dopo al dramma individuale del già citato personaggio di Justine.
Introdotta da un cartello che su sfondo nero riporta in bianco il suo nome – come avviene per tutti gli altri casi di focalizzazione sulle micro storie di singoli personaggi – la sua è la vicenda di un neo membro della comunità, ancora percepita come qualcosa di “altro, e rispetto cui il fattaccio oscuro in questione non aiuta. È nuova in città, è in pena per gli alunni della sua classe scomparsi sotto la sua tutela di maestra e, ovviamente, è fatta bersaglio principale dei sospetti dei genitori, convenzionalmente rappresentati dal furioso e determinato Archer Graff (Josh Brolin), padre dello scomparso Matthew, e proprietario di un’importante ditta edile locale.
Se nel succedersi degli episodi di diversa focalizzazione sulla medesima vicenda – prima dal punto di vista di Justine, poi di Archer e così via – Justine, Archer e il piccolo Alex rappresentano di certo le parentesi più lunghe e rappresentative, non mancano le incursioni nelle vicende più o meno collaterali e più o meno interlacciate tra loro di altri personaggi: il preside Andrew (Benedict Wong), che tenta di proteggere Justine dalle crescenti aggressioni dei locals (rimanendo più o meno spoiler free, qualcuno le scrive “WITCH” sull’auto con della vernice rossa, e questo è solo il minimo…), la redarguisce sui suoi inappropriati atteggiamenti da caregiver e detective improvvisata e, nel mentre, tenta di tener fede alla sua politica da preside distaccato in onore della tranquillità della vita sua e del suo compagno; l’agente Paul Morgan (Alden Ehrenreich), sposato con la figlia del suo superiore in comando ma invischiato in un’ambigua relazione extraconiugale con Justine, ma anche ex alcolista, paranoico e tendente a “eccessi di foga” che gradualmente ne faranno collassare status emotivo e controllo sulle sue azioni; e James (Austin Abrams), tossicodipendente che si spreme rubacchiando qua e là per una dose misera, ossia, il classico personaggio col compito della variante impazzita, più o meno vittima degli eventi che, pur non volendo attivamente fare niente, diventa uno dei motori di tutto.
Se finora, leggendo, possono esservi venuti in mente innumerevoli film e show televisivi sulla cui falsa riga avrebbe potuto muoversi Cregger, come di certo la oramai onnipresente aria alla I segreti di Twin Peaks (Twin Peaks, creata da David Lynch e Mark Frost, 1990-1991 e 2017, per la cittadina di provincia apparentemente calma e sconvolta da un qualcosa di oscuro e imponderabile), la più recente The Leftovers – Svaniti nel nulla (The Leftovers, creata da Damon Lindelof e Tom Perrotta, 2014-2017, per le persone scomparse senza chiari o credibili motivi) o, soprattutto per noi italiani, Favolacce (2020, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, per l’emergente crescita dell’inquietudine di un luogo marginale, in cui un dramma di bambini avviene alle ignare e distratte spalle delle varie figure di adulto), noi non ci sentiamo di darvi torto, eppure, per quanto certe caratteristiche di rimando ci siano – e funzionano – , forza e originalità in Weapons vengono fuori e si esaltano per altri e ben più specifici motivi.
Se, come detto, l’ultima fatica di Cregger si configura come un film a episodi/punti di vista – per cui il regista ha dichiaratamente ammesso di essersi ispirato più che altro a Magnolia (1999, Paul Thomas Anderson), per l’approccio «epico» e «senza scuse» con cui segmenta il racconto su singoli personaggi che reagiscono a un trauma tra il collettivo e l’individuale – , il risultato in fondo è null’altro che una riproposizione con variazione sul format di Barbarian, in cui già la narrazione – seppur senza dichiararlo con cartelli, come invece accade in Weapons – cambiava più volte ritmo, ambientazione, temporalità e protagonisti, intersecando vicende di personaggi di estrazioni, origini e attitudini umane differenti che restituissero un compendio sul conclamato fallimento del “sogno americano”, sulle sue ripercussioni sociali d’abbandono tanto di certe minoranze urbane o geografiche (lo spettrale quartiere diroccato e abbandonato di Detroit in cui svolge gran parte dell’azione) quanto di certe cosiddette “minoranze” (gli afroamericani, gli investitori wanna be che avevano creduto nel “sogno” o le donne, vittime di violenza e spesso destinate a replicare o ri-subire il trauma, vivendo nella paura e nella non fiducia).
Dunque, trattandosi ora non più del “solo” ambiguo b&b di periferia con annesso labirinto sotterraneo abitato da una deforme madre-mostro – e dal serial killer rapitore che tale la rese – , espandendo il raggio d’analisi ad un’intera comunità Cregger trova il suo parco giochi narrativo, in cui ogni singolo segmento – su ogni singolo personaggio – non solo aumenta a dismisura il canonico loop di tensione e paura ascendente, che quasi raggiunge il climax per poi ripartire da zero, ma – a differenza di come spesso capita quando si amplia lo stanislavskiano “cerchio dell’attenzione” a tante più cose – un maggior numero di personaggi e ambienti risulta direttamente proporzionale al grado di caratterizzazione, approfondimento e stratificazione delle singole soggettività in campo.
Rispetto a Barbarian, in Weapons la componente politica è presente, sì, ma più sfumata, amalgamata nel dialogo costante con l’emersione di dinamiche e funzionamenti comportamentali di personaggi credibili, scandagliati a fondo e senza moralizzazioni facili, tanto umani quanto fallibili e fragili, ombrosi e controversi di una genuina incoerenza…che poi è forse la formula sotto il cui significato si potrebbe raccogliere il metro compositivo di tutto il film.
Sì perché, dalla struttura sino alla moltitudine di toni e situazioni, a costituire la linfa di questa assurda e disorientante esperienza in sala, la “genuina incoerenza” si trasforma in realtà nella percezione di quanta conoscenza guidi Cregger, attraverso contrasti e eclettismi che rappresentano le infinite modalità d’approccio a un genere come l’horror, tanto specifico quanto ibrido.
In Weapons ogni episodio alterna con estrema confidenza momenti di pressione tali da schiacciarti sulla poltrona; altri di tensione irrisolvibile tra il seguire ogni singolo movimento di camera e la tentazione perenne di distogliere lo sguardo; jump-scare tra i più elementari, ma sintatticamente tanto precisi da gelare il sangue; e poi ironia sottile, risate estreme e a squarcia gola immediatamente seguite da repulsione o totale straniamento, dolcezza, eros, onirismo e violenza giustapposti ad un ritmo così serrato da sfidare ogni attesa per poi vincerla senza appello, alimentando dubbi e suggestioni che poi, purtroppo, s’infrangono sul muro inscalfibile della necessità di chiarezza.
Di fatti – e come anticipavamo introducendo, riguardo certe gravi pecche che Cregger si porterebbe dietro da Barbarian – , anche stavolta il talentuoso autore statunitense non riesce a non perdere il bando della matassa, o, a dirla meglio – se volessimo fare un parallelo figurato con il terribile scantinato del b&b del suo film d’esordio – verso tre quarti del film Cregger pare perdersi tra le mura del suo stesso labirinto di idee, demandando all’episodio sul bambino Alex il ruolo di ruspa, di ariete che tira dritto abbattendo gli ostacoli del percorso sino a un più semplice e comodo epilogo.
Non che prima di una tale flessione il film non avesse già accusato qualche lieve incertezza – anche queste piccoli ritorni dal film precedente, come figurazioni in CGI di dubbio gusto o dialoghi con impasse evitabilissime, ma funzionalmente create per complicare la risoluzione degli eventi – , ma nulla di davvero impattante o svilente di un così evidente potenziale creativo…ma quindi cosa succede?
SPOILER ALERT! (ma non eccessivo, tranquilli)
In vari momenti, durante il film – che sia il primo sogno di Justine, il sogno di Archer, o una delle nervose e disperate peregrinazioni del tossicodipendente James – vediamo comparire una figura femminile inquietante, agghindata di vestiti di pessimo gusto e pesantemente truccata di un incrostato ed eccessivo strato di biancone. Nell’incedere della vicenda una tale ricorrenza farebbe pensare alle più svariate ipotesi: dall’allucinazione collettiva a un membro rimasto ancora in ombra nella comunità, con rancori personali o strani e terribili piani su cosa fare dei poveri bambini scomparsi, e così via. La risposta finale non è però tra queste e, come spesso capita – specialmente in un contesto che vi raccontiamo quale tanto ricco, brillante e stratificato – , se non avete pensato ad un esito è perché probabilmente non è quello adatto ad arricchire o a diradare il folto mistero che avvolge Maybrook, risolto in una scelta convenzionale che, per quanto non si possa definire fallimentare, risulta di certo svilente di quanto di ottimo s’era costruito per circa un’ora e mezza…un esito purtroppo molto simile – per calo e immaginario di riferimento – alle battute finali del recente Longlegs (2024) di Oz Perkins, di certo in gamba, ma ben distante dagli intuibili potenziali ideativi di Cregger.
L’altra ipotesi, rispetto a quella del geniale autore dalle idee tanto ingarbugliate da spingerlo a semplificarle – pena l’impossibilità di uscire da un labirinto oramai inespugnabile – , potrebbe essere quella di un autore che, forse, necessita ancora di rinforzare il suo nome agli occhi delle dure necessità produttive e di chi le gestisce, abbastanza perché gli venga permessa una complessità di creazione – e quindi di fruizione, per noi spettatori – che possa rimanere coerentemente tale sino ai titoli di coda. Ma non c’è dato saperlo, noi in fondo in questa seconda ipotesi ci speriamo e, proprio per questo, siamo quanto mai curiosi del prossimo film di questo strano Cregger: talentuoso come non si vedeva dai tempi del primo Aster, parossistico, allucinatorio, capace di raccapricciare tanto col colpo di fino quanto col più becero e rodato degli escamotage e, forse, di una genialità talmente vulcanica da non esser doma neanche a lui stesso.
Per tutti questi motivi – e nonostante i difetti – , e anche nell’estate di Bring Her Back, Weapons si ritaglia con originalità uno spazio quasi da instant cult, tanto rivoluzionario da mettersi i bastoni tra le ruote da solo, eppure unico, divertente, profondamente interessante e terrificante come di rado oggigiorno capita.
Zach Cregger scrive e dirige uno degli horror più affascinanti, vari ed elettrizzanti degli ultimi anni, prendendo a piene mani dal genere nel senso più variegato, ricco e stimolante del termine e, proprio per questo, degno del più ispirato romanzo di Stephen King…quasi un adattamento dal libro che non ha mai scritto, che forse mai più scriverà ma che, se fossimo in lui, vorremmo di certo scrivere.