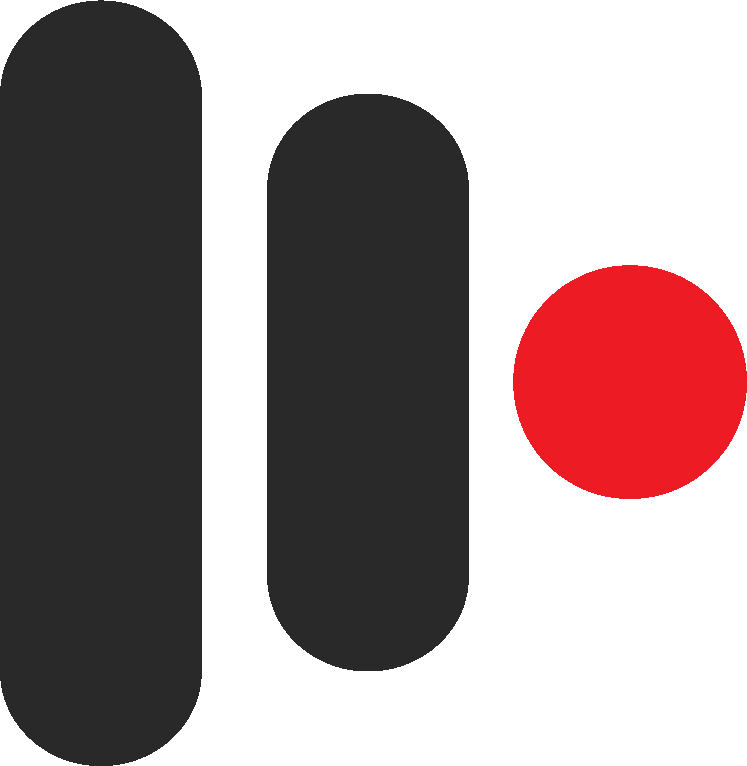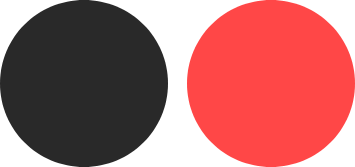Gianfranco Rosi rappresenta senza dubbio un patrimonio di grande valore per il cinema italiano: ancora una volta il documentarista si conferma figura centrale del nostro panorama culturale, presentando in concorso all’82esima Mostra del Cinema di Venezia un’opera semplice ma realizzata con tale maestria da diventare uno dei migliori film del festival.
Tra rovine e vita quotidiana, il Golfo di Napoli diventa una vera e propria macchina del tempo: passato e presente si intrecciano tra storia, fede, scavi e comunità. Il documentario esplora il nostro rapporto con il passato materiale, che attraverso l’archeologia torna a risplendere nei musei o semplicemente nei luoghi vicini alle nostre città. Rosi inserisce nel suo racconto numerose figure, ognuna con un ruolo preciso: i pompieri, una direttrice di museo, un gruppo di archeologi giapponesi, un bibliotecario che aiuta dei ragazzi nello studio, alcuni marinai siriani e, più in generale, il popolo napoletano.
Attraverso momenti diversi, distinti proprio dalla varietà di queste mansioni, Rosi unisce tutti sotto un unico cielo: quello del dialogo con il passato. Il film racconta costantemente di un’eredità da preservare che, per motivi differenti, viene invece usurpata e rovinata. I carabinieri cercano di proteggere gli scavi dai tombaroli, il museo espone ciò che la storia ci ha lasciato, gli archeologi riportano alla luce memorie sepolte, Titti (il bibliotecario) trasmette ai suoi ragazzi conoscenze di ogni genere (soprattutto storiche), mentre i marinai siriani denunciano la distruzione del patrimonio culturale di Odessa a opera della Russia.
Così, mentre da una parte del mondo un’intera città si impegna a ridare vita al nostro passato, dall’altra lo si cancella. E a compiere entrambe le azioni siamo sempre noi, esseri umani. La perfidia dell’uomo si rivela più pericolosa della natura più estrema, come il Vesuvio o i Campi Flegrei: minacce costanti e incombenti che, tuttavia, non intimoriscono l’archeologia. Basti pensare che duemila anni fa il vulcano eruttò fissando nel tempo un’intera città e “donando” (cinicamente si potrebbe dire) al futuro una storia infinita e preziosa, che oggi rischia di essere usurpata da chi non ne comprende il valore. Il tempo e la natura, almeno, sono imparziali ed equi.
Inoltre Rosi inquadra Napoli e i suoi dintorni con tale maestria da trasformare il documentario in un autentico quadro in bianco e nero: la luce che attraversa la sala e la musica di Daniel Blumberg penetrano nell’animo, accompagnando l’opera verso la sua piena riuscita.
Per concludere, vorrei proporre un’ultima riflessione su quest’opera d’arte: Rosi costruisce un racconto corale che, per Napoli, risulta estremamente attuale, quello legato alla crisi dei terremoti e all’impossibilità dei soccorsi di rispondere a tutte le esigenze. All’interno di un film dedicato all’archeologia, il regista inserisce una critica severa alla situazione presente: un gesto tutt’altro che scontato in un’opera di questo tipo.