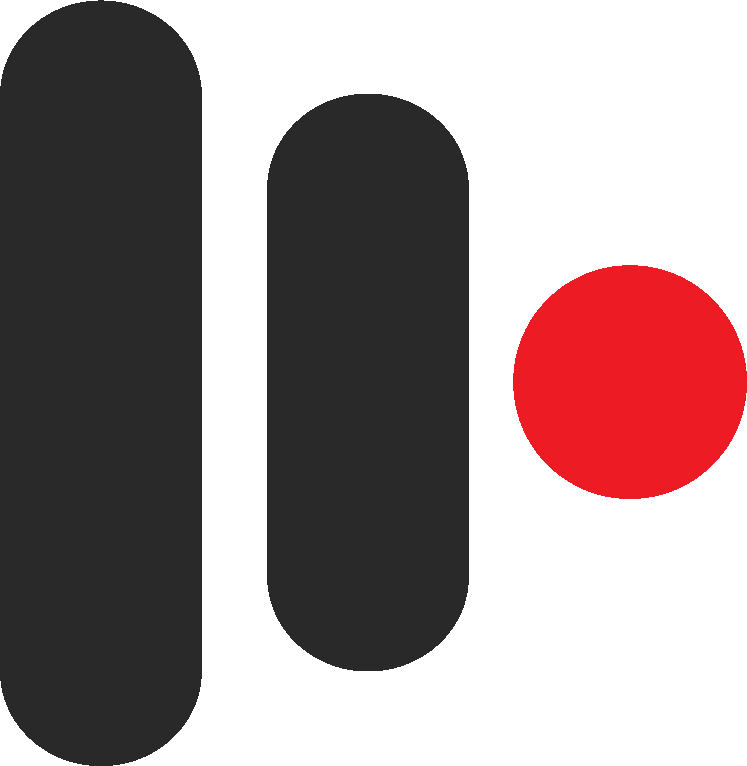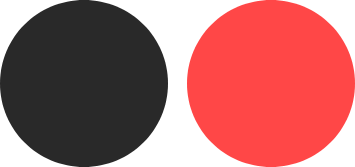È difficile negare di essere definitivamente tornati ad un cinema di volti che si vedono fin troppo, e fin troppo spesso. Tant’è che ad oggi anche l’Europa, anche la Gran Bretagna – che (non) economicamente parlando è ancora “vecchio continente” – hanno il loro Pedro Pascal: prominente tanto nella statura quanto pure nell’apertura auricolare, ma anche negli oramai sempre più evidenti accenni di talento ed interesse artistico, il cui oramai celebre nome Josh O’Connor non risulterà di certo nuovo ai più. A differenza del neo-mattatore cileno-statunitense però, almeno per ora, O’Connor ha dimostrato di non volersi rinchiudere nella posa unica del sex-symbol a cui la sua fisicità facilmente potrebbe incatenarlo, esplorando caratteri e cinematografie varie, attitudini che nel solo 2023 l’hanno portato a comparire in La chimera (Alice Rohrwacher), Lee Miller (Lee, Ellen Kuras) e Bonus Track (Julia Jackman); nel 2024 nel “solo” Challengers di Luca Guadagnino e, in questo 2025, arriva a battere il suo personale record di tre film in un anno – tour de force già affrontato nel 2015 – , siccome si attende di vederlo in Wake Up Dead Man: Knives Out (Wake Up Dead: A Knives Out Mistery) – terzo film della saga nata dal bravo Rian Johnson – e lo si è già visto sopra e sotto per la croisette dell’ultimo Festival di Cannes, presente in ben tre film della selezione ufficiale: The History of Sound (Oliver Hermanus), Rebuilding (Max Walker-Silverman) e il film di cui oggi ci occupiamo…
Un attore che si fa vedere così spesso deve anche avere la capacità ed il coraggio di scegliere da chi farsi dirigere e, in tal caso, O’Connor è stato puntuale nella partecipazione all’ultima opera di un’autrice – e di quelle con la A maiuscola – che, al contrario, non vediamo poi così spesso in sala, come al solito, e specialmente in Italia: Kelly Reichardt.
Classe 1964, dalla Florida e da Miami, l’oramai sessantunenne è di quelle registe capaci di lasciare il segno dalle retrovie, rimanendo nel cono d’ombra dell’attenzione massificata tanto per l’incedere lento, schematico e riflessivo del suo cinema, quanto per i soggetti scelti, spesso impegnati nello scandagliare singole anime erranti o immobili di certi Stati Uniti che pochi come lei analizzano e lasciano traspirare dalle increspature della pellicola, in lunga e in largo, per un carriera che dal brillante esordio con River of Grass, nel 1994, ha dato alla luce solo nove film in trent’anni…ed è andata di lusso.
Non possiamo di certo star qui a parlare di ognuna delle perle a comporre la collana di questa rara ed elegantissima carriera d’artista, ecco perché ci limitiamo solo ad elencarli brevemente dicendovi che – oltre al già citato esordio – Old Joy (2006), Wendy and Lucy (2008), Meek’s Cutoff (2010), Night Moves (2013), Certain Women (2016), First Cow (2019) e Showing Up (2022), sono tutte opere che meritano di essere attentamente cercate e apprezzate pur non avendo mai portato a casa alcun premio maggiore, perché raccontano il sogno americano nel suo deterioramento e nei suoi barlumi di rinascita ora col dramma, ora con la nuova struttura post-patriarcale di eleganti saghe familiari, ora col thriller e ora con la biografia di una mucca che si fa Stati Uniti essa stessa – sì – , in una serie di sofisticate variazioni su solitudine e ambizione in cui quest’ultimo The Mastermind si incasella perfettamente.
Anche per un’autrice che sovente si rivolge al riferimento letterario per ideare i suoi film, nel cinema vale la regola per cui la storia è importante, ma lascia il tempo che trova, e lascia lo spazio a tecnica e visione specie in un film come questo, dove all’heist movie alla Michael Mann risponde il nulla umano di Bela Tarr, la noia e l’atto senza esito di Michelangelo Antonioni; all’eleganza distante e d’alta società di Woody Allen risponde il gelo ruvido e la sconsolatezza di un giro senza meta né speranza nelle badlands, nella provincia di Terrence Malick; laddove i picchi ritmici del jazz si smorzano nel suono graffiato e distante del miglior folk di Dylan e Springsteen. Quindi la trama ve la raccontiamo, presto detto, per soffermarci poi su cosa, in questo The Mastermind di Kelly Reichardt, trasforma una buona storia in un grande film.
Nel silenzio di un sobborgo del Massachusetts del 1970, James Blaine Mooney (Josh O’Connor) – un falegname disoccupato quasi assente alla sua stessa vita, e figlio di un importante giudice della contea (Bill Camp) – decide che la sua occasione è arrivata. Insoddisfatto del suo ruolo di padre distratto e vacuo marito per la moglie Terri (Alana Haim), coltiva un’idea: insieme a due complici improvvisati penetrerà il piccolo museo locale e ruberà alcune opere d’arte, confezionando la “vita che avrebbe dovuto avere”. Il furto avviene, ma quasi subito diventa una farsa: gli ingranaggi difettano, i piani vacillano, le aspirazioni si sfaldano. E mentre la guerra del Vietnam imperversa fuori dal suo mondo domestico, J.B. si ritrova a navigare un’esistenza trascurata, dove le relazioni s’annullano all’ombra della possibile incarcerazione, e il desiderio di grandezza si risolve in una deriva on the road che ha tanto del tragico quanto del comico. Quando tutto crolla, resta solo l’uomo che ha scommesso su se stesso – e ha perso.
Le bellissime e contrappuntate melodie jazz di Rob Mazurek ci accompagnano, piano, e poi via via più concitate nella vita di un Mooney Jr. sempre al museo, in compagnia dell’eleganza distante e consapevole dell’arresa moglie ma attenta madre interpretata dall’oramai più che professionale Alana Haim – voce delle Haim assieme alla sorella e già vista in film non certo di poco conto come Licorice Pizza(2021) e Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) di Paul Thomas Anderson – , coi figli gemelli (uno docile e l’altro iperattivo) che scorrazzano per le sale mentre il nostro protagonista osserva con attenzione la guardia che dorme, la posizione dei quadri, degli oggetti e immagina il loro valore. In casa il padre lo accusa di non aver voglia di fare, la madre (Hope Davis) continua a dargli credito e fargliene, di credito, credendo alla storia dell’occasione della vita arrivata con la commissione di mobili orientali a soddisfare le voglie di un riccone che vuole arredare casa.
I soldi, ovviamente servono a James per il colpo, per pagare i due complici Guy (Eli Gelb) e Larry (Cole Doman), vecchi amici che ospita nel seminterrato della casa che condivide con la moglie – e che con tutte le forze tenta di far finta di nulla – , registrando i dubbi di questi nel coinvolgere come terzo uomo il giovane Ronnie Gibson (Javion Allen), ragazzo afro-statunitense con un passato di droghe ed un presente che lo vede interessato ai piccoli furti in provincia.
Come detto, il colpo va a segno con una discreta facilità, con la comicità grottesca e calma che serve alla Reichardt a sottolineare l’abbandono e il disinteresse delle istituzioni di provincia. Mentre il ritmo della musica si carica di picchi e distensioni, sottolineando ora l’attenzione al dettaglio, ora la macchinazione del piano e ora il furto dell’auto per scappare inosservati; l’atmosfera s’impregna di silenzi tesi e fragili, sfumature di un convincente piglio noir e di un’acuta distanza illustrativa, quasi brutalista ed esistenzialista insieme – ad includere l’uomo per poi espellerlo dal caos delle vicissitudini senza considerarlo – , nel montare sempre più entusiasta e speranzoso di quella sensazione di averla sfangata che, come si immagina sin dall’inizio, non è destinata a farsi concreta.
Se infatti è verissimo che la provincia è invisa dai centri di potere che la dimenticano, quasi se ne ricordano benissimo quando è il caso di punirne le anime che la abitano e, per bisogni più o meno legittimi, evadono una legge che li ha carcerati sin dalla nascita. Ecco che, a seguito di fatti che non stiamo qui a rivelarvi, il nome di James Blaine Mooney risalta agli occhi del governo federale, che non perde un secondo a metterlo al centro di indagini e vicende che lo vedranno nel tritacarne composto da questi ultimi, da un lato, e da ben più organizzati criminali dall’altro.
Nell’incedere il racconto assume ora le forme della saga personale e ora quelle del viaggio picaresco, alla deriva per degli Stati Uniti sottratti alla vita pubblicizzata ovunque e ammorbati da precarietà e incertezza. In tal senso diventa funzionale la scelta dell’on the road, in cui James sarà costretto a lanciarsi nel tentativo di sfuggire alle maglie della punizione che si fanno sempre più imminenti e stringenti, scoprendo la vera solitudine dovuta all’abbandono della moglie e dei figli. Tra i vari personaggi incontrati – nonché tra i più importanti – ricoprono dunque un forte ruolo simbolico i coniugi e vecchi amici di James Fred e Maude, interpretati da John Magaro e Gaby Hoffman. Entrambi ex compagni universitari del protagonista, supplente occasionale l’uno e disoccupata l’altra, vivono in una bella casa lungo il percorso di fuga di James sui sedili degli oramai iconici pulmini a forma di bussolotto metallico che con pochi dollari permettono di attraversare tutto il paese – di per loro già referente simbolico e fisico di una cultura errabonda, al cui assenza di radici non è tanto un credo quanto una frustrata necessità di un mondo che non accoglie ma sposta per produrre.
Fred accoglie volentieri l’amico, mentre Maude non lo vede di buon occhio, conscia del rischio che James risvegli nel marito quelle volontà di potere e ricchezza estorta a cui il compagno pare aver rinunciato, ora malinconico ma comunque capace di godersi la compagnia di una moglie. James ciò non l’ha accettato, ha voluto di più e si scontra con l’ingannevole mito dell’uno contro il mondo, solo, status di cui si rende conto nella sofferente voce dissimulante freddezza della moglie Terri, alla cornetta di un palazzo in città in cui James ha affittato una stanza e da cui chiama per aprire i suoi sentimenti a lei, ma non prima di aver richiesto l’ennesima somma in denaro da inviargli.
Complice il graduale inscurirsi dei toni, lo stringersi dell’obbiettivo nell’ottimo lavoro scenico del DOP Christopher Blauvet – che dal candido e quasi ameno biancore della pellicola iniziale tinge sempre più le notti di nero e blu, i paesaggi di bianca neve e le strade cittadine dei colorati segni della rivolta giovanile anti-Vietnam – , The Mastermind sa quanto sfibrare il racconto e quando ricomporlo sotto al peso di certi snodi chiave, delineando la vicenda di un singolo che presto si metaforizza in quella di una nazione intera: abbandonata, educata al surplus, inappagabile e pronta a mettersi contro tutto e tutti alla luce del suo diritto di nascita in termini di superiorità e ascesa alla grandezza. Ed è così che O’Connor pare quasi ignaro delle contestazioni pacifiste – salvo ritrovarcisi in mezzo nel bellissimo, secco e spietato finale – , ignora il faccione di Richard Nixon che lo fissa e condanna da un vicolo, e impone il corpo in un ingobbito arco di incertezza, con le mani sempre nervosamente a sfregarsi la fede al dito e gli occhi a tentare di illudere gli interlocutori di un’innocenza a cui in fondo crede davvero.
Il J.B. Mooney di O’Connor è una creatura solitaria sia per inadeguatezza che per scelta, e per l’inconscia consapevolezza di un ego così insaziabile da non poter trovare raffronto nel reale, nonché motivo principale a rendere così funzionale e azzeccata la recitazione tanto distante dell’interprete inglese.
Ed è forse il montaggio della stessa Reichardt, seppur buono, l’unico punto a sfavore in un film così piccolo nel soggetto ma così abilmente ampio nelle mire semiotiche: centrato e minuzioso nello scandagliare i micro atti focalizzati dei personaggi, tanto forte o arreso nel comunicare i picchi emotivi o asettici degli snodi principali della storia, quanto a volte eccessivamente reiterante nell’indugio su certi silenzi (a volte necessari) e certi movimenti di macchina a distrarre o scandire il tempo reale del racconto (stessa storia), finché – solo occasionalmente – a quel bel contagio di svuotamento umano dal film allo spettatore, rischia di sostituirsi qualche occasionale sfumatura di noia.
Ma questi non sono che problemi collaterali, poco impattanti per svilire gli esiti di quello che è senza dubbio un film di raffinatissima tensione tra micro e macro, tra immagine venduta e realtà viva, in cui la Reichardt mantiene altissima l’asticella della sua autorialità, senza perdersi nell’ombra del marchio MUBI con la sua pellicola e i suoi toni eterei e i suoi look vintage, affiancandosi alla statura dell’attore per cui ha scritto un gran personaggio, suggestiva e forse assai più dolorosa variazione sul tombarolo Arthur che O’Connor fu per La chimera della nostra Alice Rohrwacher.