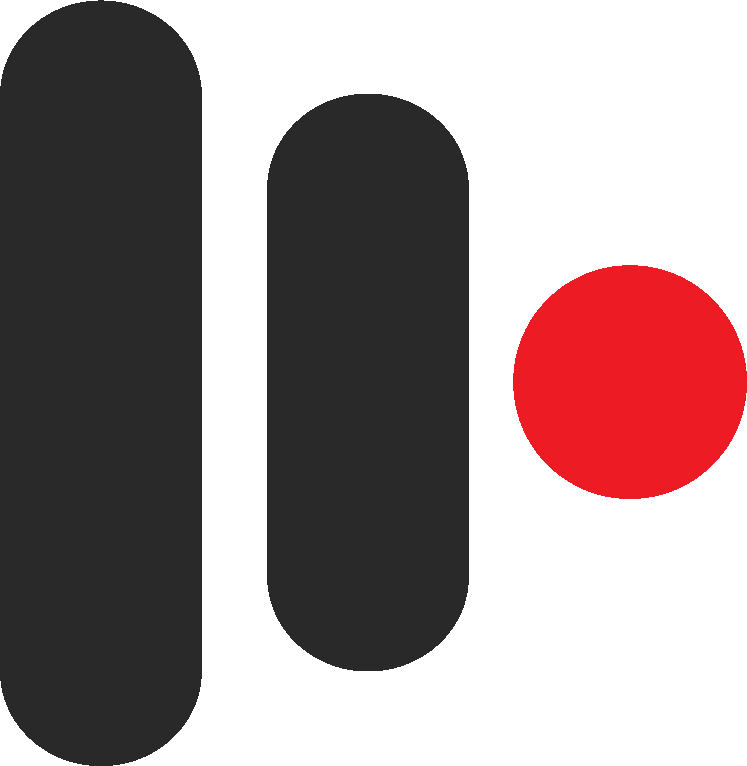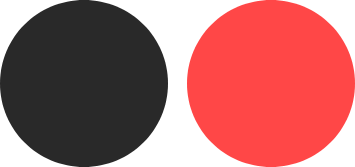L’invisibile sa ferire più a fondo del visibile. È questa la sensazione che ti lascia il film: uno status di impotenza che ti incatena, che ti fa sentire piccolo, costretto a osservare un destino ineluttabile senza poter intervenire. Una condizione che genera frustrazione, rabbia, stress, fino a spezzarsi in una disperazione muta, perché davanti a una tale crudeltà nemmeno le urla basterebbero. Resta solo il silenzio.
E allora ti aggrappi alla speranza di aver capito male, cerchi un respiro dall’altro lato, una voce che continui a chiedere aiuto, che racconti ancora la sua età, i suoi sogni, le piccole cose che la rendono felice. Speri di darle un volto, così da poterla ricordare.Ma quella voce è reale. È la voce di una bambina di sei anni, Hind Rajab, che chiede soccorso al telefono. Eppure nemmeno questo basta a smuovere i piani alti, bloccati da protocolli, autorizzazioni, attese infinite. Basta una linea che cade, una chiamata che deve passare di mano in mano, e tutto ricomincia daccapo, mentre il tempo scorre e le speranze svaniscono.
Viviamo immersi nei social, anestetizzati dal loro flusso costante. Siamo spettatori che scrollano oltre, incapaci di empatizzare davvero, anche davanti a immagini di corpi senza vita, di bambini strappati al futuro. È qui che il cinema torna a essere necessario: ci costringe a guardare, a sentire, a restare. Non ci lascia scappare.
Questo è ciò che vivono ogni giorno i soccorritori della Mezzaluna Rossa Palestinese, uomini e donne che non tornano a casa per settimane, in attesa di una chiamata che possa evitare un altro volto sulla bacheca dei caduti. Sono addestrati a mantenere la calma, ma come si può restare freddi davanti alla voce di una bambina che implora aiuto? E mentre loro parlano, il tempo continua a correre, e con esso si assottigliano le probabilità di salvezza.
Con la ricostruzione della vicenda di Hind Rajab, la regista Kaouther Ben Hania ci mette davanti alla verità, ma non scegliendo la via più semplice della rappresentazione diretta dell’orrore. Lo fa invece attraverso l’attesa, il silenzio, l’incomunicabilità, la ricerca dell’invisibile. Ci pone accanto ai soccorritori, con un telefono e una voce dall’altra parte della linea. Tutto si svolge in un unico spazio, con volti fuori fuoco che ci ricordano quanto il mondo esterno resti irraggiungibile. La regia ci costringe così a concentrarci non su ciò che vediamo, ma su ciò che non possiamo vedere: l’angoscia di un contatto che si spegne, i silenzi assordanti, l’attesa interminabile.
Ciò che resta è un silenzio che pesa più di qualsiasi immagine di guerra perché il vero dolore non è in ciò che si vede, ma in ciò che resta fuori dallo sguardo. Ed è in quel silenzio che capiamo che non possiamo più permetterci di restare spettatori passivi.